Per la determinazione della concentrazione totale di proteina in una miscela sono disponibili molte tecniche, di cui descriviamo le più comuni. Parecchi di questi metodi non forniscono un concentrazione assoluta ma relativa rispetto ad uno stock di proteina standard che viene usata per la preparazione di una retta di taratura (spesso, per il basso costo, la facile reperibilità etc. si utilizza come standard l’albumina da siero bovino, o BSA).
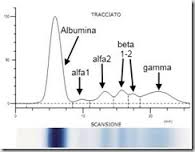
Metodo del biureto
Il reagente chiave è una soluzione fortemente alcalina di tartrato contenente solfato di rame(II) diluito. Quando la soluzione è aggiunta alla proteina, il rame si può legare alle proteine, formando un complesso colorato (si ritiene che tale complesso includa la coordinazione contemporanea di 4 gruppi peptidici con un unico ione rame). Compare un colore viola-bruno (max=540 nm) che ovviamente sarà proporzionale alla concentrazione totale dei legami peptidici e dunque di proteina.
Il metodo è generale e molto riproducibile. Purtroppo, la sensibilità è bassa: non consente in genere di misurare concentrazioni proteiche <1 mg/ml.
Metodo di Lowry – Molto usato, soprattutto nel passato. La miscela da saggiare viene dapprima portata in ambiente alcalino (pH 10-10.5) e fatta reagire con citrato o tartrato di rame(II). Dopo un certo tempo si aggiunge la miscela di Folin-Ciocalteau, il cui componente attivo è rappresentato da una miscela di sodio molibdato, fosfato e tungstato. Con l’andare del tempo si sviluppa un colore scuro, che tende al blu in presenza di proteina (in assenza, il colore tende al marrone).
L’intensità della colorazione blu (max prossima o superiore a 700 nm), sarà proporzionale alla concentrazione di proteina. Non è chiaro perché il colore blu si sviluppi, è possibile che gli acidi fosfomolibdotungstici formino dei complessi misti con rame e proteina.
Poiché la presenza e quantità dei residui aromatici (in particolare, tirosinici) influenzano fortemente per lo sviluppo del colore, sembra più probabile che il meccanismo coinvolga una riduzione dello ione Cu2+ a Cu+ da parte di questi residui, seguita da una reazione dello ione rameoso con gli acidi fosfomolibdotungstici.
Svantaggi: richiede tempi d’incubazione precisi; inoltre alcuni tamponi (come il MES) ed altre sostanze possono interferire; infine, poiché il contenuto in tirosine può influenzare la colorazione, le risposte al saggio possono variare abbastanza a seconda del tipo di proteine presenti.
Metodo dell’acido bicinconico
È un saggio molto simile a quello di Lowry, con la differenza che il rame(II) anziché in combinazione con il reagente di Folin-Ciocalteau si usa in combinazione con l’acido bicinconico. Si ritiene che la riduzione dello ione Cu2+ a Cu+ sia qui seguita dall’associazione dello ione rameoso con l’acido, con formazione di un complesso che assorbe fortemente a 562 nm (colore viola-blu). Il saggio presenta la stessa variabilità da proteina a proteina già vista per il Lowry, ma è più riproducibile e un po’ più sensibile.
Metodo di Bradford
Si basa sull’interazione non-covalente di un colorante (il Coomassie Brilliant Blue R250) con le proteine. Il saggio viene effettuato a pH acido. Il colorante si lega primariamente ai residui basici ed aromatici, e la formazione di questi complessi determina uno spostamento del massimo di assorbimento del colorante da 465 a 595 nm, che può essere misurato spettrofotometricamente. Anche se diverse proteine possono dare risposte alquanto diverse in questo saggio, la sua semplicità ed elevata sensibilità (<0.1 mg/ml) fa sì che sia largamente usato. Il Coomassie Blue si usa anche per evidenziare le bande proteiche nella gel elettroforesi.
Silver staining
Questa tecnica è usata normalmente per colorare proteine nella gel elettroforesi, nel caso sia richiesta un’elevata sensibilità. Ne riparleremo più avanti. Assorbimento nel vicino UV – La presenza degli anelli aromatici di tirosina e triptofano fa sì che le proteine presentino un assorbimento di luce nel vicino ultravioletto, con massimo a circa 280 nm. Il coefficiente di estinzione molare varia da proteina a proteina (dipende dal numero e dalla posizione degli amminoacidi aromatici), ma in genere può essere calcolato con buona approssimazione partendo dalla sequenza amminoacidica.
Tenete presente che molte altre sostanze possono assorbire nel vicino ultravioletto, e quindi condizionare i risultati della misura; fra queste gli acidi nucleici, che però hanno un massimo di assorbimento a 260 nm. A volte, nelle prime fasi di purificazione di una proteina, può essere utile verificare il rapporto tra gli assorbimenti a 280 e 260 nm, per verificare se e quanto una data frazione di proteina sia contaminata da acidi nucleici.
Peso secco
Mentre la maggior parte dei metodi visti sopra vanno benissimo per misure relative (ad es., per seguire l’aumento di attività specifica di un enzima durante la purificazione) quando si vogliano effettuare esperimenti chimici accurati con una proteina pura è necessario misurare direttamente il peso secco di un campione desalinizzato della proteina. La proteina viene dializzata estensivamente contro acqua distillata o contro un tampone volatile (ad es, carbonato d’ammonio) e poi disseccata sotto vuoto, a 50-100 °C in presenza di un agente disseccante (ad es., solfato di calcio) finché il peso non si stabilizza.
Analisi di Kjeldahl per l’azoto totale
In questo metodo “storico” il campione viene digerito bollendolo in una soluzione di acido solforico concentrato e solfato di sodio. La digestione provoca una conversione completa dell’azoto organico in ammonio. Terminata la digestione, si aggiunge un eccesso di NaOH per consentire la liberazione di ammoniaca, che viene rimossa per distillazione, raccolta in acido borico e finalmente titolata con HCl.
Il metodo è preciso e riproducibile ma molto indaginoso (anche se oggi può essere automatizzato). Soprattutto, il metodo non distingue tra azoto proteico ed azoto proveniente da altre molecole biologiche (ad es. le basi del DNA). Infine, anche se in genere si assume che gli atomi di azoto contribuiscano per circa il 16% alla massa totale delle proteine, è chiaro che in proteine diverse questa proporzione potrà cambiare anche sensibilmente.

