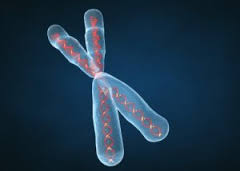Cariotipo
Cariotipo
Insieme delle caratteristiche che identificano il corredo cromosomico di una cellula, come il numero di cromosomi in essa presenti, la forma e la dimensione di ciascuno di essi; sono fondamentali anche alcune caratteristiche come, tra le altre, la posizione del centromero (un restringimento del cromosoma, che può trovarsi in posizione più o meno centrale) e la presenza di satelliti, ossia di formazioni che sporgono rispetto alla struttura a bastoncello dei cromosomi.
Il cariotipo è specie-specifico, cioè è tipico di ciascuna specie e risulta quindi uguale negli organismi che a essa appartengono. Nel cariotipo di ciascuna specie si possono riconoscere coppie di cromosomi uguali, che prendono il nome di cromosomi omologhi. Ciascuna coppia viene indicata con un numero: quando ad esempio si parla di "trisomia del 21", significa che la coppia numero 21 presenta un'anomalia, che consiste nella presenza di un cromosoma in più.
I cromosomi su cui si trovano i geni che determinano il sesso dell'individuo sono detti cromosomi sessuali e possono essere uguali fra loro oppure diversi: ad esempio, nella specie umana, il maschio possiede un cromosoma che viene indicato come X e uno che viene indicato come Y, mentre la femmina presenta due cromosomi X.
Nella costruzione di un cariotipo, si colorano i cromosomi con tecniche particolari, come il bandeggio, che delimitano regioni specifiche in ciascuna coppia di cromosomi. Le coppie di cromosomi omologhi, quindi, vengono ordinate per grandezza decrescente. Le 23 coppie del cariotipo umano sono state riunite in sette gruppi. Non esiste rapporto tra il cariotipo di una specie e la sua complessità anatomica e fisiologica.
Progetto Genoma Umano
Progetto internazionale di ricerca che ha come obiettivo la mappatura del patrimonio genetico umano (genoma), ovvero la descrizione della struttura, della posizione e della funzione dei 100.000 geni che caratterizzano la specie umana. Lo studio del genoma implica il sequenziamento del DNA, cioè l’identificazione dell’esatta sequenza dei 3 miliardi di coppie di basi azotate che ne compongono la molecola e la mappatura, ovvero la determinazione della posizione occupata da ciascun gene rispetto agli altri. La comprensione della funzione del gene e di quali malattie possano derivare da sue alterazioni costituisce l’obiettivo finale del progetto. Il Progetto Genoma Umano fu avviato nel 1990 con il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici coordinati dai National Institutes of Health (NIH), e dal Dipartimento dell’energia (DOE), degli Stati Uniti. La sua conclusione, prevista inizialmente nel 2005, fu in seguito anticipata al 2003. Tra gli stati partecipanti vi sono la Francia, la Germania, il Giappone, l'Italia, la Gran Bretagna e altri membri dell'Unione Europea.
Esistono due tipi fondamentali di tecniche per la mappatura dei geni: la mappatura genica e la mappatura fisica. La mappatura genica identifica solo l'ordine relativo dei geni lungo ciascun cromosoma; la mappatura fisica localizza la posizione esatta dei geni sui cromosomi e ne determina le distanze reciproche. Entrambi questi metodi fanno uso di marcatori genetici, ossia di particolari caratteri fisici biochimici che variano tra gli individui.
La mappatura fisica determina la distanza fisica tra alcuni punti di riferimento sui cromosomi, mediante apparecchiature computerizzate. Il DNA viene estratto dai cromosomi umani e spezzato in modo casuale in numerosi frammenti. Questi ultimi vengono riprodotti in laboratorio in cloni identici, cioè in numerose copie che possono essere analizzate a una a una allo scopo di individuare la presenza o l'assenza di specifici marcatori genetici. I cloni che condividono più marcatori molto probabilmente derivano da segmenti del cromosoma sovrapponibili, cioè molto simili fra loro. Le regioni dei cloni che si sovrappongono, quindi, possono essere confrontate per determinare l'ordine globale dei marcatori e l'esatto ordinamento dei frammenti clonati di DNA sul cromosoma
Dalla frequenza di ricombinazione tra due o più geni diversi, misurata in esperimenti di incrocio opportunamente progettati, è possibile dedurre la distanza che intercorre tra loro su ciascun cromosoma e costruire, così, mappe genetiche. L'accuratezza di queste mappe è maggiore per geni distanti che ricombinano di frequente e minore per geni vicini, che ricombinano raramente. In base ai risultati di ricerche successive agli esperimenti del genetista statunitense Thomas Hunt Morgan, è stato dimostrato che la ricombinazione può avvenire in qualunque punto del materiale genetico, anche all'interno di un singolo gene e, grazie ad alcuni metodi messi a punto di recente, è oggi possibile individuare la ricombinazione anche tra punti molto vicini di un cromosoma. La mappatura dei geni, che attualmente dispone di sofisticate strumentazioni e di tecniche innovative, come la reazione a catena della polimerasi, ha portato all’elaborazione di un progetto ambizioso, denominato Progetto Genoma Umano, per l’identificazione di tutto il patrimonio genetico della specie umana.