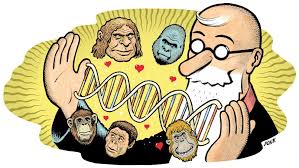Genetica di popolazione: Branca della genetica che studia la composizione genetica di una popolazione. Tale caratteristica viene misurata attraverso un parametro denominato frequenza genica, che indica la frequenza con cui un gene compare in una popolazione. La genetica di popolazione è di fondamentale importanza nei moderni studi sull’evoluzione delle specie, poiché l’evoluzione può essere interpretata come processo che determina la variazione delle frequenze geniche nel corso del tempo.
Genetica di popolazione: Branca della genetica che studia la composizione genetica di una popolazione. Tale caratteristica viene misurata attraverso un parametro denominato frequenza genica, che indica la frequenza con cui un gene compare in una popolazione. La genetica di popolazione è di fondamentale importanza nei moderni studi sull’evoluzione delle specie, poiché l’evoluzione può essere interpretata come processo che determina la variazione delle frequenze geniche nel corso del tempo. La genetica di popolazioni ha molte applicazioni anche in campo medico, in studi che riguardano, ad esempio, la diffusione dei fenomeni di resistenza agli antibiotici nei batteri e la diminuzione della diffusione del morbo di Tay-Sachs nelle popolazioni in cui sono state adottate misure di controllo della procreazione nelle coppie di portatori del gene anomalo.
Variabilità genetica
Insieme delle differenze esistenti tra organismi appartenenti a specie diverse (variabilità interspecifica) o a una stessa specie (variabilità intraspecifica). Tali differenze riguardano il patrimonio genetico (genotipo) e si riflettono sull’aspetto esterno degli organismi (fenotipo). L’analisi della variabilità genetica e dei cambiamenti delle frequenze geniche è oggetto della genetica di popolazione.
La variabilità interspecifica dipende dai diversi meccanismi evolutivi di speciazione, che portano alla nascita di nuove specie; è all’origine della biodiversità della vita sulla Terra.
La variabilità intraspecifica si manifesta tra individui che, appartenendo alla stessa specie, hanno lo stesso corredo di cromosomi e di geni, cioè di unità che controllano i diversi caratteri. Ciascun gene può esistere in due o più forme alternative, gli alleli.
Tra le teorie evoluzioniste di Lamarck vi è il cosiddetto "trasformismo", secondo il quale le prime forme di vita si originarono per generazione spontanea e diedero origine a tutte le forme più complesse per trasformazioni successive causate da mutazioni ambientali. Lamarck, inoltre, condivideva la concezione di Georges Cuvier e Geoffroy Saint-Hilaire, secondo la quale gli animali in natura erano disposti lungo una scala naturale continua. Capisaldi delle sue teorie sono i mutamenti delle strutture corporee dovuti "all'uso e al disuso delle parti" (prima legge dell'evoluzionismo lamarckiano) e "l'ereditarietà dei caratteri acquisiti" (seconda legge dell'evoluzionismo lamarckiano). Le sue ipotesi furono pubblicate per la prima volta nella Philosophie zoologique (1809) e poi riesposte in molti scritti successivi. Lamarck morì povero e cieco, e l'importanza della sua opera fu riconosciuta soltanto diverso tempo dopo la sua scomparsa.
Una teoria organica e supportata da precise osservazioni scientifiche si ebbe con L'origine delle specie di Charles Darwin, opera pubblicata nel 1859. Dopo avere compiuto importanti osservazioni nel corso di un viaggio di cinque anni sul brigantino Beagle, formulò le sue idee, per le quali risultarono determinanti anche le letture dell'opera di Thomas R. Malthus, e che risultavano quasi contemporanee alle conclusioni del naturalista britannico Alfred Russel Wallace. La teoria darwiniana si basa sull'idea che alcuni individui appartenenti a una certa specie presentano dalla nascita alcune variazioni casuali rispetto agli altri individui di quella stessa specie, che possono risultare utili in un particolare contesto, ad esempio nel caso che le condizioni ambientali si modifichino. Questi individui possono in tal senso risultare più favoriti degli altri, così da riuscire a sopravvivere e avere un maggiore successo riproduttivo. La loro prole può ereditare queste caratteristiche che, nel caso risultino ancora favorevoli, determinano una maggiore possibilità di sopravvivenza e di riproduzione anche in questa generazione; così essi trasmetteranno a loro volta alla progenie le caratteristiche che, a lungo andare, possono assommarsi ad altre caratteristiche di successiva comparsa e, infine, determinare la formazione di un gruppo di individui che, rispetto a quelli considerati all'inizio, risultano diversi. Questo processo viene detto speciazione ed è alla base della nascita di nuove specie.
Le ricerche di Mendel, riscoperte all'inizio del Novecento, dimostrarono che l'ereditarietà è dovuta alla trasmissione di generazione in generazione di particelle discrete, oggi dette geni, e non dalla miscela di molte sostanze presenti nell'organismo (come proponeva Darwin con la sua "teoria della pangenesi"). La selezione naturale agisce, pertanto, sull'effetto provocato dalla presenza, assenza o variazione di un gene in un nuovo individuo. Come fu intuito inizialmente dal matematico britannico G. H. Hardy e dal ricercatore tedesco W. Weinberg, non vi è, infatti, una tendenza innata dei geni a scomparire; se ciò si verifica, è a causa di un insieme di forze selettive naturali che agisce sugli effetti prodotti da questi geni sull'individuo che li possiede, influenzandone la probabilità di sopravvivenza e di riproduzione. La versione moderna del darwinismo, chiamata neodarwinismo, è, cioè, basata su un'interpretazione probabilistica dei fenomeni evolutivi e di selezione naturale. Essa fu elaborata negli anni Venti e Trenta dai genetisti di popolazione R.A. Fisher, John B.S. Haldane e Sewall Wright e consolidata più tardi, negli anni Quaranta, in ciò che viene oggi chiamato neodarwinismo. La rivoluzione della biologia molecolare, che ha avuto inizio negli anni Cinquanta, non ha fatto che rafforzare e confermare con dati sperimentali gli assunti teorici di questi studiosi.
La moderna teoria genetica della selezione naturale può essere riassunta come segue. I geni di una popolazione di animali o di piante che si riproducono per via sessuale costituiscono un pool genico. I geni in un certo senso competono tra loro nel pool genico, come le prime molecole autoreplicanti competevano nel brodo primordiale.
Nel pool genico, ogni nuovo gene si origina a causa di una mutazione, un errore casuale che può verificarsi a livello dei geni. Una volta che, mediante mutazione, si è formata una nuova variante di un gene, questa entra a far parte del pool genico di una popolazione perché, mediante la riproduzione sessuale, essa può venire trasmessa ad altri individui.
Qualunque gene di un pool genico esiste in numerose varianti, tutte dovute a mutazioni avvenute a un certo punto della storia evolutiva di quel gene. Tutte le varianti di uno stesso gene sono dette alleli e, a seconda della frequenza o rarità di ciascun allele all'interno del pool genico, si parla di alta o bassa frequenza allelica (o genica) (si può, ad esempio, parlare di una determinata frequenza che in una popolazione hanno gli alleli che codificano per il colore azzurro o marrone degli occhi). A livello genetico, l'evoluzione può essere definita come il processo con cui la frequenza allelica varia in un pool genico.
La frequenza allelica può essere modificata a causa di fattori quali: la mortalità e l'emigrazione; la riproduzione e l'immigrazione; il caso o deriva genetica; la mutazione.
Consideriamo, ad esempio, gli alleli responsabili della lunghezza delle ali in una popolazione di moscerini della frutta: se una popolazione possiede alleli che producono ali più lunghe e un'altra ali più corte, questa differenza di caratteri può riflettersi in tassi di mortalità diversi, oppure nella differente capacità di volare che permette all'una, ma non all'altra, di emigrare in un altro areale. Tutti questi fenomeni, guidati da forze selettive, alla fine producono una variazione delle frequenze alleliche nel pool genico. Gli altri due fattori fanno, invece, variare le frequenze in modo più diretto: la deriva genetica è quella parte di variazione delle frequenze alleliche dovuta al caso, mentre le mutazioni di un allele in un altro sono un evento raro e, quindi, non influiscono molto sulle variazioni di frequenza allelica.
Le frequenze alleliche di una popolazione possono essere utilizzate per prevedere con quale frequenza i diversi genotipi compaiono in quella stessa popolazione.
La frequenza effettiva di un genotipo in una popolazione si ottiene invece dividendo il numero degli individui caratterizzati da quel genotipo per il numero degli individui che formano la popolazione.
La legge di Hardy-Weinberg descrive, mediante alcune relazioni algebriche, come in una popolazione la frequenza dei differenti geni non si modifichi nel tempo. In particolare, le equazioni algebriche esprimono con quale frequenza determinati alleli compaiano in una popolazione e con quale frequenza in quella stessa popolazione compaiano certi genotipi. Attraverso lo studio delle frequenze alleliche e genotipiche, i genetisti possono determinare quali raggruppamenti di individui stiano cambiando da un punto di vista genetico, cioè quali siano in fase di evoluzione; essi possono anche prevedere l’incidenza di difetti genetici.
L’equilibrio si verifica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: la popolazione è isolata, cioè non vi sono fenomeni di emigrazione o di immigrazione di individui; l’accoppiamento tra i membri della popolazione avviene in modo casuale; le probabilità di riproduzione e sopravvivenza sono equivalenti in tutti gli individui; non si verificano mutazioni; la popolazione è molto numerosa.