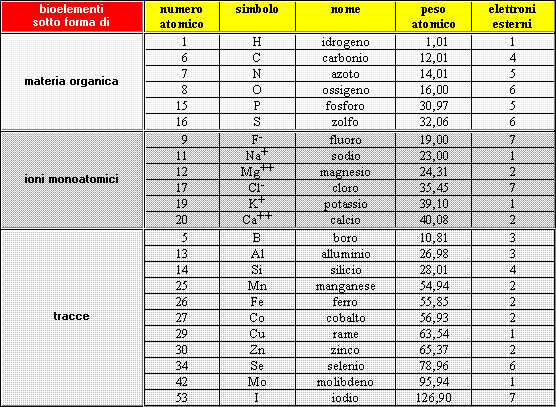Atomi
• particelle subatomiche:
o protoni (carica elett. + ; massa = 1.66 x 10-24 g)
o elettroni (carica elett. – ; massa = 0)
o neutroni (senza carica elettr.; massa = 1.66 x 10-24 g)
• nucleo (protoni & neutroni)
• attorno al nucleo ruotano (su orbitali) gli elettroni in n° = n° protoni
• carica elettrica netta atomo = 0
• legami chimici:
Atomi
• particelle subatomiche:
o protoni (carica elett. + ; massa = 1.66 x 10-24 g)
o elettroni (carica elett. – ; massa = 0)
o neutroni (senza carica elettr.; massa = 1.66 x 10-24 g)
• nucleo (protoni & neutroni)
• attorno al nucleo ruotano (su orbitali) gli elettroni in n° = n° protoni
• carica elettrica netta atomo = 0
• legami chimici:
o ionico:
Ø atomo perde elettroni ®ione + (catione)
Ø atomo acquista elettroni ®ione – (anione)
Ø legami ionici (forza con la quale ioni di senso opposto si attraggono) ®composti ionici
o covalente:
Ø due atomi condividono un elettrone ciascuno (doppietto elettronico) ®legame semplice
Ø due doppietti condivisi ®doppio legame, etc.
Ø atomi uniti da legame covalente ®molecola
Ø se doppietto fornito dallo stesso atomo ®legame dativo
• reazioni chimiche ®formazione o rottura di legami chimici
Forze intermolecolari o Forze di van der Waals – Forze di attrazione o repulsione che si manifestano tra le molecole di una sostanza, determinandone lo stato di aggregazione. Si tratta di forze di natura elettrica, di intensità sensibilmente minore rispetto a quelle che determinano la formazione dei legami chimici tra gli atomi. Oltre a influire sullo stato di aggregazione della sostanza, tali forze sono alla base di diversi fenomeni fisici e chimici quali l'adesione, l'attrito, la diffusione, la tensione superficiale, la viscosità e le deviazioni del comportamento dei gas rispetto alla legge dei gas perfetti. Si tratta di forze a corto range, vale a dire, che si esercitano a breve distanza.
Le forze intermolecolari attrattive, dette complessivamente “di van der Waals”, possono essere di tre tipi, a seconda delle caratteristiche della sostanza: forze di interazione dipolo-dipolo, che si esercitano tra molecole polari, di interazione tra dipoli istantanei, caratteristiche delle sostanze non polari, e di interazione dipolo-dipolo indotto, con caratteristiche intermedie tra le due. Inoltre, è una forza intermolecolare attrattiva anche quella responsabile del legame di idrogeno.
• due atomi con lo stesso numero atomico (ugual n° protoni ed elettroni, diverso n° neutroni) ®isotopi dello stesso elemento (stesse proprietà chimiche, massa diversa)
• massa atomi e molecole misurata in dalton
Acqua
L'acqua costituisce una frazione compresa tra il 50 e il 90 % del peso corporeo degli organismi viventi, potendo raggiungere in alcuni invertebrati marini addirittura il 95 % del peso totale. Il protoplasma cellulare è una soluzione colloidale macromolecolare in cui l'acqua rappresenta l'elemento disperdente; grassi, carboidrati, proteine, sali e altre sostanze chimiche vengono disciolte e trasportate in soluzione acquosa, e ciò permette le numerose reazioni chimiche indispensabili per i cicli fisiologici. Il sangue degli organismi animali e la linfa delle piante sono costituiti prevalentemente da acqua, che ha la funzione di trasportare le sostanze nutritive e di rimuovere i prodotti di rifiuto. L'acqua svolge inoltre un ruolo fondamentale nel metabolismo delle cellule, prendendo parte a diverse reazioni di idrolisi.
La molecola dell'acqua è costituita da un atomo di ossigeno e da due atomi di idrogeno, disposti a formare un angolo di circa 108°. L'alta elettronegatività dell'ossigeno, che consiste nella sua proprietà di attirare con maggior forza gli elettroni di legame, fa sì che la distribuzione delle cariche elettriche nella molecola non sia uniforme, ma polare. Questa caratteristica è responsabile di diverse proprietà specifiche dell'acqua, tra cui il fatto di avere una densità maggiore allo stato liquido che allo stato solido.
Il legame idrogeno è un legame chimico che si forma tra molecole che contengono un atomo di idrogeno legato a un atomo fortemente elettronegativo (ossia che richiama verso di sé gli elettroni di legame). Molecole di questo tipo posseggono una polarità molto marcata, dovuta al fatto che al loro interno si determinano un polo di carica negativa (intorno all'atomo elettronegativo) e uno di carica positiva (intorno all'idrogeno). Il legame idrogeno si può realizzare proprio perché i poli di carica opposta di ciascuna molecola si attraggono reciprocamente; è questo tipo di legame a determinare lo stato liquido dell'acqua a temperatura ambiente.
I composti ionici sono solubili nell’acqua. Grazie alla loro carica, gli ioni possono stabilire forti interazioni elettrostatiche con le molecole d’acqua. Si crea così, attorno ad ogni ione un guscio di molecole d’acqua, orientate tutte nella stessa direzione e trattenute da forte interazioni con l’ione stesso.
Composti polari – sono solubili nell’acqua, presentano gruppi donatori e gruppi accettatori di legami a idrogeno (carboidrati, amminoacidi).
Composti apolari – sono insolubili nell’acqua, non possono formare legami a idrogeno con l’acqua, in quanto non posseggono né gruppi donatori, né atomi accettori di legami a idrogeno. Per venire trasportati nei liquidi biologici (es.: nel sangue), devono interagire con molecole solubili in acqua che fungano da trasportatori (es.: la molecola di ossigeno è apolare e viene trasportata dall’emoglobina, proteina capace di legare l’ossigeno a livello dei polmoni e di liberarlo a livello dei tessuti).
Composti anfipatici (o anfifilici), composti la cui molecola presenta una porzione polare (solubile nell’acqua) ed una porzione apolare (insolubile in acqua): saponi, lipidi polari (o complessi). Tali composti, in acqua, si trovano sottoposti a due tendenze contrapposte: da una parte, la loro porzione polare tenderebbe a trascinarli in soluzione, dall’altra, la loro porzione apolare tenderebbe a farli separare dall’acqua. Tre casi.
Le molecole si aggregano fra di loro mettendo a contatto le loro porzioni apolari che interagiscono tra loro, formando legami Van der Waals, esponendo le posizioni polari verso l’acqua, che interagiscono con essa. Le particelle che si formano sono dette micelle.
Nell’acqua sono presenti fasi polari e apolari; in questo caso i componenti antipatici sono disposti con le porzioni apolari rivolte verso la fase apolare e le porzioni polari verso l’acqua. In questo modo si forma un foglietto monomolecolare di composti antipatici che separano le due fasi.
Le molecole antipatiche (in particolare i lipidi polari) formano membrane costituite da un foglietto bimolecolare che delimitano vescicole dette liposomi. In questa struttura, i foglietti monomolecolari si affacciano uno contro l’altro e mettono a contatto le loro facce apolari, escludendole dall’acqua, mentre le porzioni polari interagiscono con l’acqua.
Dissociazione dell’acqua – dell’acqua nei suoi elementi fondamentali, dando origine a protoni (H+) e ossidriloni (OH).
Carbonio
Carbonio – Elemento chimico di simbolo C e numero atomico 6, appartenente al gruppo IVA (o 14) della tavola periodica. È il costituente fondamentale di tutti i composti organici, biologici e non, e riveste quindi un ruolo molto importante nella vita degli organismi viventi.
Composti alifatici – Composti organici contenenti nella molecola una catena aperta di atomi di carbonio: questa loro caratteristica li distingue dai composti aromatici, l’altro grande gruppo in cui vengono suddivise le sostanze organiche, caratterizzati invece dal fatto di essere costituiti da anelli di carbonio formati da numero ben preciso (4n + 2) di atomi.
I composti organici alifatici possono essere suddivisi in cinque classi principali: gli idrocarburi, gli alcoli, le aldeidi e i chetoni, gli acidi carbossilici e le ammine. È possibile rappresentare tali composti mediante il gruppo funzionale preceduto dalla lettera R, che indica un generico residuo di idrocarburo.