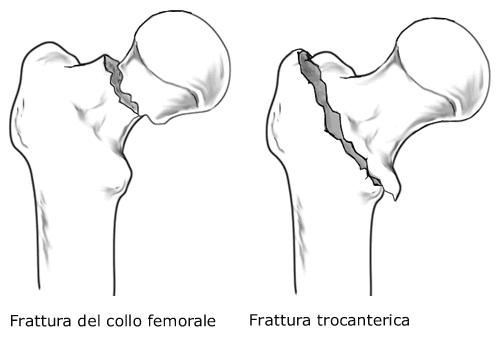Sono in assoluto la patologia più frequente e più impegnativa di un reparto di Ortopedia e Traumatologia. Sono più frequenti nelle donne (rapporto 2:1) e rappresentano la complicanza più grave dell’osteopatia osteoporotica post-menopausale e senile.
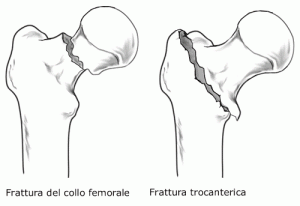
Il sesso più colpito è quello femminile perché la drastica riduzione del tasso di ormoni estrogeni che si verifica dopo la menopausa nella donna indebolisce notevolmente la struttura ossea in generale, ma soprattutto alcune sedi elettive:
- collo del femore,
- polso,
- rachide,
- epifisi prossimale dell’omero.
Queste fratture un tempo erano considerate la causa più frequente di mortalità delle persone anziane in quanto o non guarivano ovvero costringevano a lunghi periodi di immobilizzazione a letto con le conseguenze che ne derivano: piaghe da decubito, broncopolmoniti, decadimento organistico, insufficienza cardiorespiratoria.
Femore com’è fatto
La regione prossimale del femore è costituita dalla testa femorale, dal collo propriamente detto, dalla regione trocanterica (piccolo e grande trocantere).
Lo studio anatomico della zona riveste notevole importanza in quanto la rima di frattura di queste lesioni può interessare una regione di osso femorale intracapsulare o extracapsulare e ciò ha conseguenze notevoli per la guarigione di queste fratture.
L’irrorazione della regione della testa femorale avviene attraverso l’arteria del legamento rotondo, che proviene dalla zona centrocotiloidea e raggiunge il centro della testa femorale (fovea capitis), e attraverso le arterie capsulari (anteriore e posteriore) che raggiungono la base del collo femorale.
Una lesione frattura la cui rima cadrà in una regione del collo femorale prima della inserzione caspulare priverà del contingente ematico nutritizio delle arterie caspulari la testa femorale; questa pertanto riceverà sangue e quindi nutrimento solo dall’arteria centrale del legamento rotondo; se questa arteria è preda di processi aterosclerotici ovvero è trombizzata (come frequentemente si osserva nell’anziano) il sangue nutritizio alla testa femorale sarà scarso o nullo e pertanto la regola sarà la necrosi della testa del femore.
Distinzioni delle fratture del collo del femore
Pertanto queste considerazioni hanno indotto a distinguere le fratture del collo del femore in fratture mediali, quelle che capitano all’interno dell’inserzione capsulare sul collo (fratture cos. transcervicali, sottocapitate, basicervicali), e in fratture laterali, quelle la cui rima cade in corrispondenza dell’inserzione capsulare o subito all’esterno (fratture basi-trocanteriche, fratture pertrocanteriche, sottotrocanteriche). Le fratture laterali, o in generale le fratture trocanteriche, erano definite benigne in quanto la consolidazione era la regola, quelle mediali, o in generale le fratture transcervicali, erano definite maligne in quanto la necrosi della testa femorale è la regola.
Il trattamento di queste fratture del collo del femore dovrà pertanto tenere conto di questi presupposti. Un trattamento conservativo non chirurgico ovvero un trattamento chirurgico che prevede un’osteosintesi sarà destinato al fallimento nel caso delle fratture mediali, mentre sarà coronato da successo nelle fratture laterali trocanteriche.
Fratture mediali del femore
Le fratture mediali in soggetti giovani, nei quali si può presumere che la testa possa ricevere sangue nutritizio dall’arteria centrale non obliterata del legamento rotondo, e che non si presentano molto scomposte, possono richiedere un trattamento chirurgico che prevede l’osteosintesi. In tutti gli altri casi di fratture mediali (trancervicali p.d., sottocapitate etc.) il trattamento dovrà essere chiurgico e consisterà in una artroplastica sostitutiva con protesi parziale o totale di anca.
Fratture laterali del femore
Le fratture laterali prevedono un trattamento chirurgico di osteosintesi (chiodo gamma, chiodo placca, vite-placca, etc.) l’unico che permette di mobilizzare questi ammalati per lo più anziani, migliorarne le possibilità di nursing e consentire una rapida deambulazione.