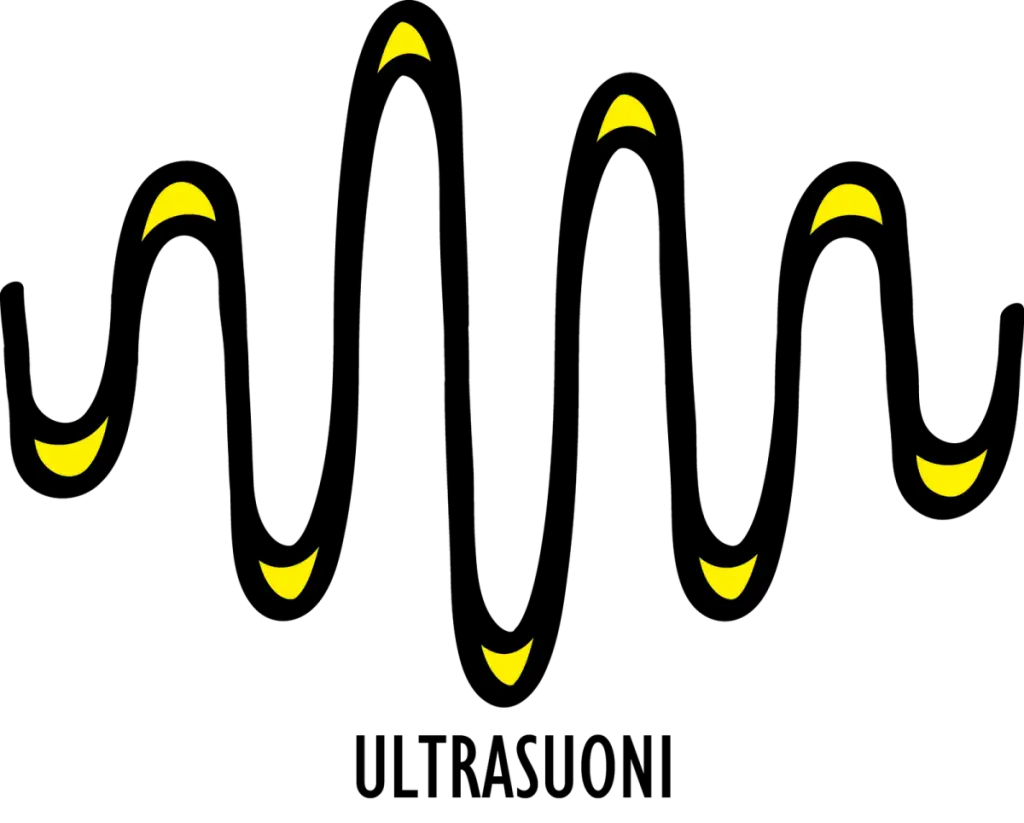Le tecniche audiologiche strumentali permettono di capire, innanzitutto, se il soggetto sente o non sente e di distinguere una ipoacusia trasmissiva da una neurosensoriale.
Innanzitutto, la prima grossa differenziazione si fa tra tecniche audiometriche soggettive e oggettive, dove soggettivo ed oggettivo significano rispettivamente che è richiesta o non la collaborazione del paziente.
Le tecniche audiologiche strumentali permettono di capire, innanzitutto, se il soggetto sente o non sente e di distinguere una ipoacusia trasmissiva da una neurosensoriale.
Innanzitutto, la prima grossa differenziazione si fa tra tecniche audiometriche soggettive e oggettive, dove soggettivo ed oggettivo significano rispettivamente che è richiesta o non la collaborazione del paziente.
Questa differenziazione, per quanto possa sembrare banale e intuitiva, è importante perché esistono alcune categorie dove la collaborazione non è possibile (ad esempio nei bambini troppo piccoli) o non è voluta (in medicina legale o delle assicurazioni possono esserci delle persone che simulano sia una sordità per motivi risarcitori o un buon udito per motivi lavorativi per non venir esclusi da quel posto di lavoro); ci sono poi, ovviamente, tutti gli adulti che non possono collaborare o perché sono in coma o sono neurologicamente non presenti o pazienti psichiatrici (basti pensare ad un soggetto autistico dove molto spesso si crea il dubbio se non risponde perché autistico o perché realmente non sente).
Dunque, si hanno tecniche audiometriche che si avvalgono della collaborazione del paziente e tecniche audiometriche che, invece, possono fare a meno di questa collaborazione.
Le tecniche audiometriche soggettive sono un insieme di tecniche finalizzate a valutare quantitativamente e qualitativamente una perdita di udito e richiedono la collaborazione del paziente. Questa prima parte comprende tutte le audiometrie che utilizzano, come materiale per l’esecuzione del test, toni (audiometria tonale)oppure materiale vocale (audiometria vocale).
A proposito delle audiometrie tonali, è bene precisare che si distinguono un’audiometria tonale liminaree un’audiometria tonale sopraliminare: i termini “liminare” e “sopraliminare” vogliono, rispettivamente, dire “soglia” e “sotto-soglia”; complessivamente, trattasi di test fatti a intensità molto basse per cercare la soglia uditiva e di test fatti a intensità più forti (sopra-soglia, appunto) finalizzati a cercare evidentemente altro.
L’audiometria comportamentale, invece, è un’audiometria semi-oggettiva, ovvero è sempre dipendente dalla collaborazione del paziente, ma è una collaborazione ‘indotta’; tale metodica, in genere, si esegue su bambini piccoli che ancora hanno un’età che non consente loro di collaborare per bene, per cui si studiano le risposte comportamentali.
Le tecniche audiometriche oggettive, invece, utilizzano dei test obiettivi che non hanno bisogno della collaborazione del paziente; sostanzialmente, trattasi di test che fanno tutto da soli, indipendentemente dalla collaborazione del paziente, che può limitarsi al solo star fermo anziché muoversi in continuazione.
Fanno parte di tali tecniche, innanzitutto, le otoemissioni acustiche (SOAEs, TEOAEs, DPOAEs), che sfruttano il fenomeno delle otoemissioni acustiche, cioè il fatto che l’orecchio produca dei suoni data la presenza delle cellule ciliate esterne che, contraendosi, producono rumori definiti, appunto, otoemissioni. Ebbene, esistono degli strumenti capaci di registrare queste otoemissioni che possono essere spontanee o evocate: nella maggior parte delle persone con udito normale è possibile registrare tali otoemissioni senza nessuno stimolo, oppure, è possibile registrarle in risposta a uno stimolo.
Tecniche oggettive sono anche i test impedenziometrici e timpano-metrici, i riflessi cocleo-stapediali (RCS), ma soprattutto i test di elettrofisiologia (l’elettrofisiologia è una sorta di audiometria per risposte elettriche; così come si registra l’attività elettrica del cuore o quella encefalica, si registra anche l’attività elettrica in risposta a uno stimolo uditivo).
In particolare, i potenziali evocati uditivi sono una risposta evocata da uno stimolo uditivo lungo la via uditiva; praticamente, l’esecuzione dei potenziali evocati consente di registrare una risposta elettrica che compare in risposta a uno stimolo che viene inviato al paziente. In realtà, di potenziali evocati ce ne sono diversi: elettrococleografia (ECochG); potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (A.B.R.); potenziali a latenza intermedia (M.L.R.)/a lunga latenza (L.L.R.)/correlati all’evento(E.R.P.).
Ciò che differenzia tutti questi potenziali sono, oltre alla metodica e al tipo di stimolo, soprattutto il tempo (ad esempio, se si manda uno stimolo uditivo all’orecchio destro, tale stimolo prende la via uditiva per arrivare alla corteccia: per esempio, a 1 ms lo stimolo sarà a livello troncoencefalico, a 10 ms sarà un po’ più su, a 300 ms sarà a livello corticale. Quindi, questi diversi potenziali altro non sono che potenziali registrati a tempi diversi e, quindi, in sede diversa, perché il segnale nel frattempo sta viaggiando. Il termine “latenza” indica proprio il tempo che passa tra la presentazione dello stimolo e la comparsa della risposta elettrica).
Di tutti i potenziali evocati sopraelencati, quelli che interessano maggiormente sono l’elettrococleografia (che è proprio il potenziale iniziale legato al punto di passaggio tra coclea e nervo acustico, da cui appunto il nome) e i potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (o A.B.R.): sono questi quelli che si registrano con maggiore facilità dal punto di vista elettrico.
I potenziali evocati uditivi sono utili, non solo dal punto di vista audiometrico (cioè, per darci una quantità della capacità uditiva del soggetto), ma anche dal punto di vista della diagnosi topografica ed etiologica, nel senso che i potenziali evocati uditivi, siccome indagano il percorso del segnale uditivo dalla periferia verso i centri, possono dare delle informazioni e delle risposte circa la differenziazione tra ipoacusie cocleari e ipoacusie retrococleari: non a caso, il primo test che si fa per la differenziazione di un’ipoacusia neurosensoriale, se è a sede cocleare o a sede retrococleare, sono proprio i potenziali evocati uditivi (Generalmente, si utilizzano proprio gli ABR).
Per quanto riguarda l’impedenziometria, la timpanometria e i riflessi cocleo-stapediali, si può dire che tutti e tre le metodiche fanno parte dello stesso tipo di esame, l’IMPEDENZIOMETRIA, che studia l’opposizione o la cedevolezza (che sono due aspetti della stessa medaglia) che il sistema timpano-ossiculare (cioè, il sistema membrana e ossicini) oppone o offre all’onda sonora. In altri termini, l’impedenziometria studia l’impedenza o la cedevolezza (l’ostacolo) che trova lo stimolo uditivo e, quindi, l’onda sonora, sbattendo sulla membrana timpanica e venendo trasmessa poi attraverso la catena ossiculare.
L’impedenziometria consta di due parti: la timpanometria e i riflessi cocleo-stapediali. La timpanometria misura proprio direttamente la cedevolezza di questo sistema ed è estremamente utile, non tanto dal punto di vista della misurazione dell’udito (non è, quindi, una tecnica audiometrica in senso stretto), quanto per capire come sta l’orecchio medio (per capire se, eventualmente, c’è del catarro o un qualsiasi altro blocco o se, per esempio, la tuba uditiva non funziona).
Cosa diversa sono i riflessi cocleo-stapediali: essi registrano il riflesso cocleo-stapediale, cioè l’attività del muscolo stapedio (innervato dal nervo faciale) che si inserisce sulla catena ossiculare. Complessivamente, il riflesso cocleo-stapediale è il riflesso che genera la contrazione del muscolo stapedio, il quale si inserisce sulla catena ossiculare e che, contraendosi e irrigidendo la catena stessa, ha, sostanzialmente, la finalità di evitare il passaggio di suoni troppo intensi che potrebbero arrecare danno alle strutture cocleari. In pratica, se il suono è molto intenso, è molto soprasoglia, si evoca automaticamente questo riflesso, il sistema si irrigidisce e con l’impedenzometria si è in grado di rilevare e registrare tutto ciò.
Tale test, oltre a dare informazioni sull’integrità di questo riflesso, dà anche indirettamente delle informazioni uditive: ciò avviene perché il riflesso cocleo-stapediale compare generalmente a 70dB sopra la soglia; pertanto, se si sta registrando questo riflesso e la soglia del riflesso è a 90dB (cioè, si mandano 90dB e si registra che il riflesso compare), intuitivamente, visto che normalmente il riflesso compare a 70dB sopra la soglia, la soglia potrebbe essere intorno ai 20dB. Sono tutte informazioni che non hanno bisogno della collaborazione del paziente.