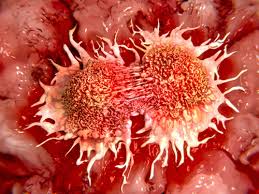Le terapie per i tumori maligni possono essere chirurgiche, farmacologiche o radianti. Questi sono i tre pilastri su cui si fonda attualmente la terapia antitumorale.
A questi si aggiungono, in alcuni casi particolari, terapie ormonali (nei tumori ormone-responsivi), immunitarie (con cellule o anticorpi), biologiche (es. trapianto di midollo ematopoietico o somministrazione di immunomodulanti, cioè sostanze che modulano la risposta immunitaria. Vi sono anche alcune forme di terapia genica del tutto sperimentali).
Le terapie per i tumori maligni possono essere chirurgiche, farmacologiche o radianti. Questi sono i tre pilastri su cui si fonda attualmente la terapia antitumorale.
A questi si aggiungono, in alcuni casi particolari, terapie ormonali (nei tumori ormone-responsivi), immunitarie (con cellule o anticorpi), biologiche (es. trapianto di midollo ematopoietico o somministrazione di immunomodulanti, cioè sostanze che modulano la risposta immunitaria. Vi sono anche alcune forme di terapia genica del tutto sperimentali).
Le terapie biologiche acquistano oggi sempre maggiore importanza perché con i tre pilastri si è raggiunto un plateau di successi terapeutici. Allora si cercano nuove strade.
Frequentemente si fa uso di associazioni terapeutiche anche perché si interviene con la terapia quando la neoplasia è già un po’ avanzata.
Nella fase in cui il tumore è piccolo ma diagnosticabile (1-8 cm3) si può quasi sempre intervenire chirurgicamente e l’intervento chirurgico è risolutivo. Nelle fasi successive l’intervento chirurgico non è da solo sufficiente e ad esso bisogna associare una terapia.
Una forma particolare di terapia è la “terapia neoadiuvante”: prima dell’intervento chirurgico, per migliorarne l’efficacia, si interviene spesso per ridurre la massa neoplastica.
Chemioterapia:
Esistono delle neoplasie che rispondono molto bene alla chemioterapia (gruppo I):
· Un gruppo di leucemie;
· Malattia di Hodgkin;
· Alcuni tumori pediatrici;
· Carcinomi a piccole cellule del testicolo.
Ci sono però delle neoplasia che rispondono malissimo (gruppo IV), alcune delle quali sono molto diffuse:
· Carcinomi del rene, del colon-retto, della cervice e del pancreas;
· Adenocarcinoma del polmone;
· Melanoma maligno.
Per inciso il cancro della mammella e della prostata appartengono al gruppo II.
I farmaci agiscono su diversi siti della cellula in modo che essa sia attaccata su diversi fronti: esistono degli alchilanti del DNA, degli antimetaboliti etc…
Malgrado ciò non si riesce ad ottenere un farmaco selettivo per l’elemento neoplastico: in sostanza i chemioterapici sono tossici.
A breve termine la chemioterapia provoca nausea, vomito, brividi, febbre ed eruzione cutanea.
Precocemente possono comparire leucopenia, plastrinopenia (che è la causa più importante che limita la progressione della terapia), mucosite nella bocca e nell’esofago, caduta dei capelli
A lungo termine si può riscontrare anemia, neurotossicità periferica, azospermia e amenorrea, danni epatocellulari…
Infine tardivamente possono comparire leucemie o tumori solidi causati da un meccanismo di cancerogenesi iatrogena: tutti i farmaci chemioterapici sono essi stessi dei cancerogeni.
Risposta alla terapia e resistenza
La risposta che si può ottenere alla terapia è:
· Remissione completa:regressione completa di tutti i segni ed i sintomi di neoplasia per la durata minima di un mese;
· Regressione parziale:regressione di più del 50% della somma del prodotto dei due diametri di tutte le lesioni misurabili per la durata minima di un mese;
· Miglioramento obiettivo:regressione del 25-50%, non influisce sulla sopravvivenza;
· Progressione:aumento del 25% del volume della massa neoplastica oppure comparsa di nuove metastasi;
· Ricaduta:comparsa di nuove lesioni oppure aumento del 50% rispetto ai valori preterapeutici dopo un periodo di remissione completa o parziale.
I motivi per cui, nonostante la terapia, avviene progressione o ricaduta è che si sviluppano a livello di popolazione neoplastica dei meccanismi di resistenza.
I tipi di resistenza sono essenzialmente due:
1. Temporanea:
· se ci sono componenti cellulari inaccessibili (santuari farmacologici), per esempio a causa della barriera ematoencefalica;
· diminuita vascolarizzazione o limitata diffusione dei farmaci;
· alterata cinetica cellulare: ad esempio bassa frazione di crescita.
2. Permanente:
· Presenza, in elevata proporzione, di fenotipi cellulari geneticamente resistenti ad uno o più farmaci.
Un esempio di resistenza è la resistenza pleiotropica o MDR (multiple drug resistance): la cellula diventa resistente a farmaci diversi. Ciò può essere dovuto alla glicoproteina di membrana p170: una pompa che cerca di allontanare dalla cellula sostanze estranee.
Se questo meccanismo è efficiente, magari per amplificazione genica, allora il farmaco non riesce a raggiungere in concentrazioni sufficienti il suo bersaglio molecolare. Per ovviare a questo problema oggi si fa polichemioterapia, in modo da aggredire la cellula su più fronti.
Nuovi tentativi terapeutici
2. Uso di oligoantisenso per bloccare la trascrizione di particolari geni alterati (es. RAS). Il problema è che è difficile veicolare queste molecole all’interno delle cellule;
3. nel cromosoma Philadelphia si produce una tirosin chinasi BCR-ABL. E’ stata messa a punto una molecola, surrogato dell’ATP (necessaria per l’attività chinasica), specificatamente selettiva per questa proteina. In questa maniera forme di leucemia mieloide cronica sono curate molto bene;
4. inibizione della tirosin chinasi responsiva a fattori di crescita con particolari farmaci. Purtroppo solo nel 20% dei casi si può applicare la terapia e solo per la durata di sei mesi prima che intervengano meccanismi di resistenza. Però questa terapia è priva di effetti collaterali;
5. uso, contro alcuni tipi di tumori, di anticorpi monoclonali. Il Cd20 è una molecola che si trova nelle cellule dei linfomi non-Hodgkin. Il legame Ag-Ac sulla superficie provoca apoptosi diretta;
6. Radioimmunoterapia: uso di un anticorpo monoclonale che veicola una sostanza radioattiva. La tossicità per i tessuti normali è ridotta.