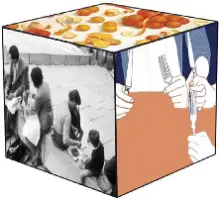I modi di alimentarsi delle famiglie e degli individui nel nostro paese, in altre parole le combinazioni di piatti e menù, è talmente vario da regione a regione, che una descrizione esauriente richiederebbe varie pagine colme di dati, cifre e grafici. Tale problema è particolarmente accentuato nel nostro paese, dove l’esistenza di numerosissime realtà e tradizioni locali, dovute a svariati fattori, in primis le numerose e varie colonizzazioni ed influssi avute nel corso dei secoli, dai nord europei ai turchi ed ai nord africani, hanno fatto sì che il modo di alimentarsi sia tra i più vari che si possano trovare al mondo. Pertanto, la descrizione delle abitudini alimentari non può che far riferimento a dati statistici relativi a qualità e quantità rilevate nelle varie parti del paese.
Se si risale indietro nel tempo, fino alla metà del secolo scorso, quando cioè si compiva l’unità nazionale, il quadro generale dei consumi nella nostra popolazione, anche attraverso i pochi dati a disposizione, offre l’immagine di una mensa molto povera, ed il più delle volte, in vaste zone e per talune classi sociali, al di sotto dei livelli minimi di sussistenza. A tale proposito, nella “inchiesta agraria” diretta da Stefano Iacini, e resa nota nel 1883, si legge testualmente “l’alimentazione di gran parte degli italiani è scarsa e di infima qualità, anzi peggiore di quella che sarebbe da desiderarsi che fosse“.
Tuttavia, col trascorrere dei decenni e con il miglioramento delle condizioni economiche del Paese, anche la situazione alimentare generale si evolve in senso positivo, giungendo così agli inizi di questo secolo, ad una razione di consumo che, anche se non può considerarsi adeguata, specie dal punto di vista qualitativo, rappresenta un notevole progresso rispetto al secolo precedente.
Si tratta sempre di una razione molto povera di alimenti di origine animale, ma che non dà più quel quadro di “fame diffusa” per larghi strati della popolazione. Migliorano soprattutto le condizioni alimentari delle popolazioni urbane e della classe operaia inserita nell’industria, mentre rimane grave e carente lo stato di alimentazione della classe contadina meridionale.
Il vero balzo in avanti si verifica all’inizio degli anni cinquanta, quando, superato il periodo bellico, la crescita industriale ed economica del Paese, porta un sensibile incremento del reddito pro-capite, e con esso quel salto di qualità che si è evoluto ed affinato nel corso degli anni, fino ad i nostri giorni. Negli anni cinquanta ogni italiano consumava mediamente non oltre 600 Kg di alimenti e bevande pro-capite annui. Tale consumo raggiunge e supera negli anni scorsi i 900 Kg .
Gli aumenti più rilevanti riguardano soprattutto i consumi di prodotti di origine animale: molto marcato quello delle carni, di misura inferiore, ma sempre notevole, quello di latte, formaggi, uova e grassi animali; modesto invece, il consumo di pesce.
Per quanto attiene l’andamento dei consumi di prodotti di origine vegetale, il fenomeno è più articolato. I generi alimentari il cui consumo risulta più aumentato, sono i prodotti ortofrutticoli, i grassi da condimento, lo zucchero. E’ cresciuto il consumo di frumento, mentre è diminuito quello dei cosiddetti cereali minori (mais, segale, orzo e riso) e dei legumi secchi. Stazionario può considerarsi il consumo di patate.
Anche nel consumo della frutta vi è un andamento differenziato: gli italiani hanno consumato negli ultimi decenni una quantità crescente di mele, pere, pesche, fichi ecc.. con un incremento crescente negli ultimissimi anni di agrumi in genere, fragole, Kiwi e frutta esotica di importazione. Lo sviluppo del settore lattiero caseario ha reso possibile un sensibile incremento del consumo dei relativi prodotti.
Che la cucina italiana sia differente da regione a regione è un fatto noto. Ciò che forse è meno noto è la rilevante differenza di consumi, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, sia per il tipo di alimenti consumati. Si può concludere affermando, che in nessun altro paese vi è una differenza così marcata tra regioni diverse di uno stesso Stato, ed è questo un aspetto di grande importanza quando si voglia valutare il livello alimentare, o quando si vogliano fornire indicazioni di orientamento ed educazione nutrizionale.
Altro aspetto di cui si ritiene opportuno solo accennare, che influenza sia il tipo di alimenti consumati, sia la quantità, sono quelli legati a fattori abitudinari, alle tradizioni, al reddito individuale, al livello culturale, all’ambito famigliare ecc..
Tutti gli esseri viventi si moltiplicano, accrescono e riparano le continue usure dei propri costituenti strutturali e funzionali. Oltre a produrre e mantenere le proprie strutture, tutte le cellule viventi debbono anche eseguire particolari funzioni indispensabili alle proprie necessità vitali o alla economia gestionale dell’organismo.
In un certo senso gli esseri viventi possono essere considerati delle macchine che, oltre ad eseguire determinate funzioni, possiedono la capacità di moltiplicarsi, autogenerarsi, e di riparare i danni prodotti dalla loro usura. Per soddisfare queste molteplici necessità, ogni essere vivente ha bisogno di prelevare dal mondo esterno una certa quantità di materiali da usare, sia per fabbricare le proprie strutture, sia per produrre l’energia necessaria a far funzionare la macchina vivente.
Questa operazione di prelievo di materiale dal mondo esterno, viene definita in senso lato con il termine di alimentazione. Mediante l’alimentazione ci si procura: proteine, grassi, glucidi, sali minerali, vitamine ed acqua. Tutto questo materiale viene introdotto nel canale alimentare, dove viene scisso nei componenti più semplici di ogni classe di composti. Questo processo prende il nome di digestione.
La digestione viene compiuta da una serie di enzimi prodotti dalle pareti del tubo gastrointestinale, o dalle ghiandole annesse all’apparato digerente ( salivari, fegato, pancreas ).“Prima digestio fit in ore”. La prima digestione si faccia in bocca, dicevano i Latini.
Infatti, attraverso la masticazione il cibo si mescola alla saliva la quale inizia a predigerire le grosse molecole di zuccheri, stimolando in tal modo la secrezione dei succhi gastrici, pancreatici e biliari, migliorando così l’intero processo. Tra l’altro migliora anche la sensibilità ai sapori. Lo scopo della digestione è quello di ottenere, dal materiale complesso ed eterogeneo di origine alimentare, i costituenti semplici fondamentali delle varie classi di composti in forma solubile, che sono introdotti nell’organismo attraverso la parete intestinale. La digestione è infatti seguita dall’assorbimento del materiale digerito.
L’assorbimento è un fenomeno attivo, cioè le varie sostanze non passano attraverso la parete intestinale per semplice diffusione, ma vengono prelevate attivamente e selettivamente dalle cellule della mucosa intestinale. Il compito della mucosa è duplice: da un lato preleva il materiale digerito presente nel lume intestinale, dall’altro trasferisce questo materiale nel torrente circolatorio sia sanguigno, sia linfatico.
Una volta passato in circolo, il materiale viene distribuito a tutte le cellule dell’organismo. Le cellule di tutti i tessuti possono usare questo materiale per i loro immediati bisogni vitali, oppure possono immagazzinarlo in attesa di utilizzarlo al momento opportuno. L’utilizzazione dei vari costituenti provenienti dall’alimentazione, da parte delle cellule e dei tessuti, si compie con procedimenti complessi che prendono il nome generico di metabolismo.