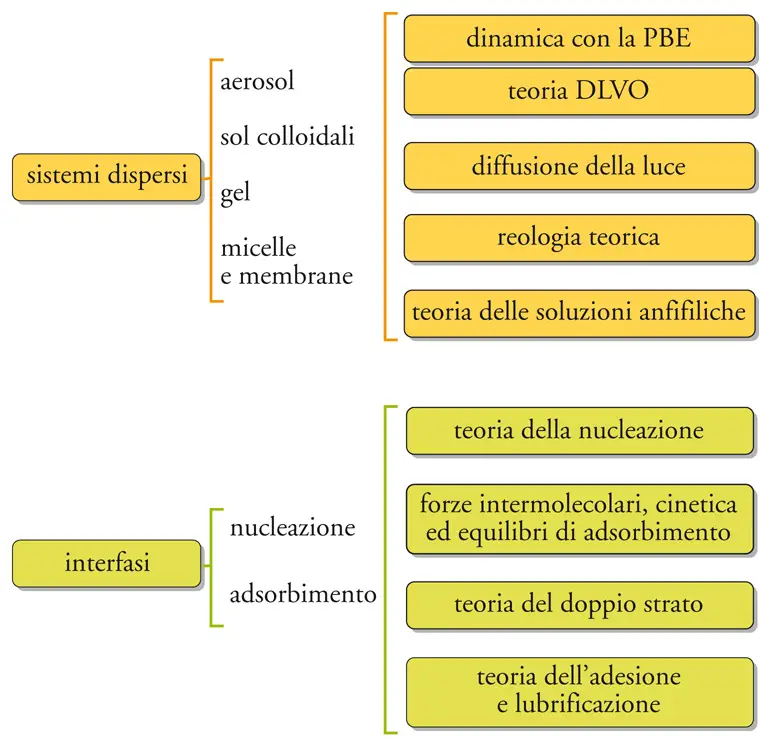Si può effettuare una classificazione dei sistemi dispersi in base alle dimensioni del materiale disperso, si individuano così tre classi:
ñ Dispersioni molecolari (soluzioni vere) – le particelle hanno dimensioni inferiori a 1,0nm e sono invisibili al microscopio elettronico; attraversano ultrafiltri e dializzano, diffondono rapidamente.
ñ Dispersioni colloidali (pseudosoluzioni) – le particelle hanno dimensioni comprese tra 1nm e 0,5μm e sono visibili al microscopio elettronico e all’ultramicroscopio; attraversano filtri di carta ma non dializzano, diffondono molto lentamente.
ñ Dispersioni grossolane – le particelle hanno un diametro maggiore di 0,5μm e sono visibili al microscopio ottico; non passano filtri di carta e non diffondono.
Sulla base delle interazioni delle particelle, molecole o ioni della fase dispersa con le molecole del mezzo disperdente i sistemi colloidali possono essere classificati in tre gruppi: liofili, liofobi e d’associazione.
Colloidi liofili: Sono sistemi che contengono particelle colloidali che interagiscono in modo apprezzabile con il mezzo disperdente formando dispersioni colloidali o soli con relativa facilità. L’attrazione tra la fase dispersa e la fase disperdente è favorita dalla solvatazione, capacità delle particele di circondarsi di uno strato di molecole di solvente che le rende facilmente disperdibili.
Posseggono gruppi a carattere idrofilo (OH, COOH, NH2) capaci di formare legami a idrogeno con l’acqua. Si hanno sia prodotti naturali (gomme vegetali, gelatina, amido), che semisintetici (metilcellulosa, carbossimetilcellulosa), che sintetici (polivinilpirrolidone).
Le dispersioni colloidali idrofile (soli o mucillagini) possono trasformarsi in geli (gelatine) quando le molecole della fase dispersa formano un reticolo nelle cui maglie restano racchiuse le molecole di acqua. L’evaporazione dell’acqua produce uno “xerogel” che ritorna gel per semplice aggiunta di acqua. Si può avere il fenomeno della sineresi, trasudamento di un sottile velo di liquido da parte del gel a riposo, lento ed irreversibile.
Colloidi liofobi: Sono materiali, principalmente composti inorganici, con scarsa affinità e attrazione per il mezzo disperdente, non si ha la transizione sol/gel in quanto non presentano un rivestimento di solvente attorno alle particelle. La dispersione colloidale, molto meno stabile, avviene per effetto delle cariche elettriche apportate da ioni adsorbiti sulla superficie delle particelle.L’aggiunta di elettroliti provoca precipitazione del colloide per attrazione elettrostatica.
Per i colloidi liofobi si possono utilizzare due distinti metodi di preparazione:
Metodo di dispersione: con il quale si riducono a dimensioni colloidali le particelle grossolane (disgregazione meccanica con molini normali e molini colloidali, apparecchi generatori di ultrasuoni, produzione di archi elettrici nel liquido disperdente).
Metodo di condensazione: con il quale si induce l’aggregazione di un elevato numero di particelle di dimensioni subcolloidali (molecolari od atomiche) per formare particelle collidali; basato su reazioni chimiche (ossidazione, idrolisi, ecc.).
Colloidi d’associazione: Sono molecole amfifile (tensioattivi) adsorbite all’interfaccia del sistema con affinità per solventi polari e apolari. Abbassano la tensione superficiale di un liquido puro anche in piccolissime quantità. Formano uno strato che, per essere efficace, deve ricoprire integralmente la superficie del liquido, ma è sufficiente che abbia lo spessore di una molecola. Se la sostanza non è in quantità sufficiente per coprire tutta la superficie, la tensione superficiale è influenzata marginalmente.
In un mezzo liquido a basse concentrazioni sono presenti come unità separate e sono di dimensioni subcolloidali; all’aumentare della concentrazione tendono ad aggregarsi dando origine alle micelle (50 o più monomeri; il numero di monomeri corrisponde al numero di aggregazione). La formazione dei colloidi d’associazione è spontanea purché la concentrazione dell’amfifilo in soluzione superi la concentrazione micellare critica (CMC).
Proprietà dei colloidi:
ñ Proprietà ottiche,
◦ Effetto Tyndall verificabile con l’uso dell’ultramicroscopio,
◦ Forma, grandezza e struttura (microscopio elettronico),
◦ Torbidità (dispersione della luce),
ñ Proprietà cinetiche,
◦ Movimenti Browniani,
◦ Diffusione,
◦ Sedimentazione,
ñ Proprietà elettriche,
◦ Fenomeni elettrocinetici,
Proprietà elettriche dei colloidi,
Le particelle disperse in un mezzo liquido possono sviluppare una carica elettrica superficiale che origina principalmente da due meccanismi: adsorbimento selettivo di particolari specie ioniche in soluzione (es ioni aggiunti all’acqua o ioni H+/OH-); ionizzazione di gruppi posti sulla superficie della particella (esempio il gruppo COOH).
Avendo una carica elettrica le particelle si dispongono nel mezzo acquoso secondo la teoria del doppio strato elettrico: consideriamo la superficie solida di una particella a contatto con una soluzione contenente ioni e supponiamo che alcuni cationi vengano adsorbiti sulla sua superficie impartendole una carica superficiale positiva, mentre in soluzione rimangono altri cationi e tutti gli anioni. Questi anioni saranno attratti dalla superficie carica positivamente a formare uno strato elettrico (aa’-bb’) costituito da molecole di solvente e alcuni cationi come controioni; questo strato, o strato di stern, si muove con la superficie solida e rappresenta il piano di scorrimento effettivo. Sovrapposto al primo si avrà un altro strato (bb’-cc’) costituito prevalentemente da cationi, strato diffuso.
Il potenziale di Nerst rappresenta la differenza di potenziale tra la superficie della particella e la regione elettricamente neutra; il potenziale zeta invece è la la differenza di potenziale tra la superficie bb’ e e la regione elettricamente neutra. Se in un sistema prevalgono le forze repulsive (potenziale zeta alto) le particelle di segno uguale si respingono; se invece prevalgono le forze attrattive (potenziale zeta basso) le particelle si aggregano per formare i flocculi.
La stabilità dei colloidi avviene principalmente attraverso due sistemi: impartendo una carica alle particelle disperse o circondando ciascuna particella con uno strato di solvente che sia in grado di prevenire la coesione delle particelle durante la collisione (indotta dai moti Browniani). Le interazione tra le particelle colloidali in una dispersione sono dovute alla risultante tra la repulsione elettrostatica e l’attrazione di tipo van der Waals.
Quando due particelle in un mezzo acquoso di opportuna concentrazione elettrolitica si avvicinano esiste una debole forza attrattiva appena oltre la zona delle forze repulsive dovute al doppio strato (minimo secondario, responsabile della flocculazione).
Una barriera repulsiva (massimo primario) separa il minimo secondario dal minimo primario. La grandezza della forza repulsiva al massimo primario determina se un sistema flocculato rimarrà tale; se l’energia termica del sistema è tale da superare la barriera repulsiva allora le particelle potranno avvicinarsi molto le une alle altre e stabilire una forte attrezione a livello del minimo primario (coagulazione).
I colloidi allo stato di sol sono poco frequenti, si possono ricordare:
ñ PVP come sostituto sintetico del plasma (idrofili).
ñ Cloruro d’argento e argento proteinato, usati come antibatterici meno irritanti sotto forma colloidale (idrofobi).
Gli usi più comuni sono per la preparazione di emulsioni, sospensioni, geli;per migliorare la solubilità e la stabilità o il sapore di principi attivi in preparazioni acquose od oleose; attualmente molti sistemi colloidali (liposomi, nanosfere, microemulsioni) vengono studiati per un rilascio modificato e selettivo di farmaci.
Una caratteristica dei sistemi dispersi è lo sviluppo sempre molto elevato dell’area interfacciale, cioè dell’area della superficie di contatto tra la fase dispersa e la fase continua, da cui si ha un’elevata energia libera associata:
W = γ S
Un elevato valore di W comporta instabilità con conseguente aggregazione spontanea delle particelle per ridurre S (dispersioni liofobe); un basso valore di W determina la stabilità del sistema (dispersioni liofile).
Sospensioni: Sono sistemi costituiti da un solido disperso in un liquido in cui è insolubile o solo parzialmente solubile. Nella realizzazione di una sospensione, estrema importanza rivestono le dimensioni delle particelle di fase solida (in genere comprese tra 0.1 e 100 μm): quanto più piccole sono le particelle e quanto più uniformi sono le loro dimensioni, tanto maggiore sarà la stabilità della sospensione. Il fenomeno di instabilità che si osserva con più frequenza nel caso delle sospensioni è la sedimentazione: la sedimentazione è ammessa per la forma farmaceutica, purché essa non porti alla formazione di un sedimento compatto di difficile o impossibile risospensione (cake).
Le sospensioni possono avere vari impieghi in campo farmaceutico, quali: uso orale, uso intramuscolare o sottocutaneo, uso topico, forma di deposito in TTS, uso in aerosol.
Le sospensioni sono sistemi instabili, hanno un’alto valore di energia libera, a causa dell’alto valore di superficie specifica; per questo si utilizzano opportuni tensioattivi per ridurre l’energia libera mantenendo però gli stessi valori superficiali.
Sedimentazione:
È il processo per effetto del quale le particelle disperse in un liquido di densità minore si depositano sul fondo del contenitore. La velocità di sedimentazione delle particelle viene espressa dalla legge di Stokes:
v = [d2 (ρs – ρ0) g]/ 18η
Questa legge è però valida solo per sospensioni molto diluite (inferiori al 2% m/v) di particelle sferiche, rigide e di grandezza uniforme che sedimentano senza turbolenza. Se v risulta negativo le particelle non sedimentano ma galleggiano e si ha il fenomeno della flottazione.
Se le particelle si attraggono con deboli forze, rimangono separate da un sottile strato di liquido e formano aggregati porosi (flocculi); se le particelle si attraggono con forze considerevoli, vengono strettamente in contatto e formano un precipitato compatto (cake).
In un sistema flocculato le particelle disperse si aggregano e sedimentano molto velocemente; la velocità di sedimentazione dipende dalla porosità dell’aggregato. Il surnatante diventa chiaro appena la sospensione è lasciata a riposo, il sedimento intrappola molto liquido con un volume finale molto grande ed è facilmente ridisperdibile per semplice agitazione.
In un sistema deflocculato invece le particelle disperse rimangono come unità separate e la velocità di sedimentazione è lenta, il surnatante continua a rimanere torbido per un tempo prolungato dopo l’agitazione. La lenta velocità di sedimentazione previene l’intrappolamento di liquido nel sedimento che diventa molto compatto e molto difficile da ridisperdere (caking).
Il grado di sedimentazione è definito come il rapporto tra il volume del sedimento e il volume totale della sospensione:
F = Vsed/V0 = hsed/h0
Il grado di flocculazione invece è il rapporto tra il volume della sospensione flocculata e il volume della sospensione deflocculata:
β = F / F∞
La flocculazione si può controllare attraverso l’uso di diversi tipi di agenti flocculanti:
ñ Elettroliti – alterano il potenziale zeta facilitando la flocculazione; i più usati sono gli ioni mono e bivalenti.
ñ Polimeri – agiscono sia come protettori impedendo alle particelle che sedimentano di formare un deposito compatto, sia come flocculanti in quanto parte della loro catena si adsorbe sulla superficie delle particelle con formazione di ponti tra le particelle sospese; tra i più usati si hanno gomme naturali, derivati solubili della cellulosa e gelatina.
ñ Tensioattivi – i tensioattivi ionici si comportano come gli elettroliti in quanto vengono adsorbiti sulla superficie solida dapprima neutralizzando e poi invertendo la carica; quelli non ionici inducono ponti tra le particelle dovute all’adsorbimento di micelle o molecole di tensioattivo, in questo caso anche se la carica rimane costante si ha l’aumento della dimensione della particella.
Preparazione delle sospensioni:
Le sospensioni possono essere preparate in due modi: o sospendendo il farmaco nel veicolo simultaneamente alla sua formazione oppure sospendendo il farmaco nel veicolo già preparato.
Il procedimento iniziale consiste sempre nel ridurre il solido a particelle di adatte dimensioni, si tratta poi con un agente bagnante e si disperde nel mezzo:
ñ le particelle vengono addizionate con un opportuno agente flocculante e unite al liquido disperdente;
ñ le particelle non vengono flocculate ma incorporate in un liquido strutturato, cioè trattato con un agente ispessente che ne aumenta la viscosità e la densità (gomma arabica o adragante);
ñ le particelle vengono addizionate con un agente flocculante ed incorporate in un liquido strutturato.
La sospensione si prepara in molini colloidali, mentre se deve essere sterile si scioglie una forma solubile del principio attivo in un adatto veicolo e la soluzione sterilizzata per filtrazione verrà precipitata a formare la sospensione desiderata.
Controlli di qualità:
ñ Granulometria – è importante mettere in evidenza eventuali fenomeni di ingrossamento delle particelle specialmente per sospensioni parenterali e oftalmiche. Si utilizzano il microscopio o il coulter counter.
ñ Sedimentazione/risospendibilità – si ritengono buone sospensioni quelle in cui l’altezza del sedimento e del 90% circa rispetto all’altezza totale; sono accettati sedimenti anche maggiori purchè siano completamente risospendibili.
ñ Viscosità – la misurazione si effettua con viscosimetri rotazionali.
ñ Densità – la misura si effettua con densimetri di precisione e serve per rilevare eventuali incorporazioni d’aria durante la preparazione.
ñ Invecchiamento accelerato – si mantiene la sospensione per tre mesi a 40 °C e 75% UR; si effettuano poi cicli di caldo/freddo.
ñ Titolo dei principi attivi – deve essere conforme alle specifiche del prodotto.
Emulsioni: Sono sistemi termodinamicamente instabili formati da almeno due fasi liquide immiscibili, una delle quali è dispersa nell’altra sotto forma di goccioline. La fase dispersa è detta anche interna o discontinua; quella disperdente è chiamata anche esterna o continua.
Le emulsioni possono essere:
ñ emulsioni olio in acqua (O/A) – in cui si ha l’acqua come fase esterna;
ñ emulsioni acqua in olio (A/O) – in cui si ha l’olio come fase esterna;
ñ emulsioni miste (A/O/A) – in cui le gocce di acqua sono disperse in gocce più grandi di olio a loro volta disperse in acqua.
Le emulsioni gel presentano agenti gelificanti mentre le emulsioni trasparenti hanno le gocce della fase dispersa inferiori a 50μm (invisibili a occhio nudo).
Le emulsioni sono molto usate in campo farmaceutico sia per uso esterno, come creme idrofobe (A/O) e idrofile (O/A), sia per uso orale, in quanto attenuano il sapore sgradevole di alcuni oli e permettono di somministrare farmaci insolubili in acqua.
Essendo sistemi termodinamicamente instabili è necessario aggiungere un agente emulsionante, agente attivo a livello dell’interfaccia. Quando una fase acquosa ed una oleosa vengono mescolate si formano goccioline di varia dimensione alla cui interfaccia esiste una tensione tanto maggiore quanto maggiore è il grado di immiscibilità.
La produzione di una emulsione richiede lavoro:
W=γS
La tensione interfacciale è una misura della forza che deve essere vinta per mescolare le due fasi. Qualsiasi sostanza capace di abbassare la tensione interfacciale renderà più agevole la preparazione di un emulsione.
I fattori che determinano le emulsioni sono:
ñ Volume di fase – la fase presente in quantità maggiore avrà maggior tendenza a costituire la fase continua con opportuni tensioattivi e per determinati valori di viscosità, si può limitare fino al 10% la percentuale di fase continua nell’emulsione inversione dell’emulsione (da O/A a A/O).
ñ Viscosità delle fasi – la fase più viscosa si suddividerà meno facilmente producendo un minor numero di globuli fase continua.
ñ Caratteristiche del tensioattivo (regola di Bancroft) – la fase continua è quella in cui il tensioattivo è più solubile.
ñ Metodo di preparazione – la fase che si versa sotto agitazione costituirà la fase interna.
Tensioattivi: Il tensioattivo deve permettere la diminuzione della tensione interfacciale; la diminuzione del lavoro necessario per ottenere una dispersione; non deve essere troppo solubile in una delle due fasi, deve quindi avere un’attività idro-lipofila bilanciata. Se l’emulsionante ha carattere idrofilo prevalente si formeranno emulsioni O/A e viceversa. Tra gli agenti emulsionanti oltre ai tensioattivi si hanno anche colloidi idrofili e particelle solide finemente suddivise. Il tensioattivo forma un film monomolecolare che può produrre forze elettriche repulsive tra le gocce ed agire come barriera meccanica alla coalescenza.
Tensioattivi anionici: Saponi (sali alcalini e alcalinoterrosi o di basi organiche di acidi con più di C14); saponi alcalini (stearato di sodio e potassio).
Tensioattivi cationici: Non sono usati come emulsionanti ma come antibatterici (cloruro di benzalconio, cetrimide).
tensioattivi anfiionici: Presentano sia un gruppo anionico che uno cationico (lecitina).
Tensioattivi non ionici idrofili: Esteri ed eteri di glicoli polietilenici.
Aggregazione e coalescenza: È l’unione spontanea di goccioline di emulsione per formare gocce più grosse con la completa separazione delle fasi e la rottura dell’emulsione. Per evitare questo problema talvolta è utile affiancare all’emulsionante primario agenti emulsionatori secondari.
Inversione di fase: L’inversione può avvenire quando si aggiunge ad un’emulsione un elettrolita che può reagire con l’emulsionante cambiandone le caratteristiche.
Preparazione delle emulsioni: Le emulsioni possono essere preparate con due diversi metodi:
ñ Metodo continentale (o per sospensione): l’emulsionante viene disperso nel liquido che costituirà la fase interna. A questa sospensione si aggiunge poi, sotto agitazione, l’altro componente continuando l’agitazione per un tempo conveniente.
ñ Metodo inglese (o per soluzione): l’emulsionante viene disciolto nel liquido che costituirà la fase disperdente od esterna al sistema. A questa soluzione si aggiungerà a piccole porzioni, sotto energica agitazione la fase dispersa dall’emulsionante.
L’agitazione permette inizialmente la formazione delle gocce ma non deve essere eccessiva perché con l’agitazione aumenta la probabilità di collisione tra le gocce stesse e quindi la probabilità di aggregazione.
Per la preparazione delle emulsioni si hanno principalmente quattro tipi di apparecchiature:
ñ Mescolatori ed agitatori (bassa velocità, turboemulsori) – a bassa velocità sono convenienti solo per emulsioni semplici; quelli ad alta velocità sono più efficaci anche se non utili per mescolare emulsioni con alta viscosità. I turboemulsori sono ottimi con preparazioni piuttosto fluide.
ñ Emulsionatori ad ultrasuoni o magnetici – l’azione emulsionatrice è dovuta all’azione di cavitazione prodotta o da un vibratore elettromagnetico o da vibrazioni ultrasoniche.
ñ Omogenizzatori (alte pressioni attraverso piccoli orifizi) – si rompono gli agglomerati e si riducono le dimensioni della fase interna ottenendo una dispersione fine e stabile.
ñ Molino colloidale.
Per determinare che il tipo di emulsione prodotto sia quello richiesto (A/O od O/A) si possono usare vari metodi:
ñ diluizione – se una data emulsione è diluibile in acqua (ad es., latte, maionese) è di tipo O/A;
ñ uso di coloranti – un’emulsione addizionata con un colorante idrosolubile (ad es., blu di metilene) risulterà uniformemente colorata se è di tipo O/A;
ñ conducibilità elettrica – solo le emulsioni di tipo O/A permetteranno il passaggio di corrente fra due elettrodi;
ñ fluorescenza – la maggior parte degli olii, e quindi le emulsioni A/O, emettono fluorescenza se eccitati con radiazioni elettromagnetiche di opportuna lunghezza d’onda.
Controlli di qualità:
ñ Aspetto fisico – il sistema deve essere omogeneo o in caso di creaming si deve poter riformare l’emulsione per agitazione.
ñ Dimensione dei globuli – può rivelare la tendenza di un’emulsione alla colalescenza; si effettua con microscopio o coulter counter.
ñ Stabilità delle sostanze attive – si valuta per tutto il periodo di validità anche attraverso l’invecchiamento precoce: Variazioni di temperatura: mantenimento dell’emulsione a 40-50 °C per tempi variabili da 1 a 3 mesi; Alternanza di cicli a bassa e ad alta temperatura (a 4°C per 48 ore e 40°C per 48 ore per la durata di 1-2 mesi). Centrifugazione (sollecitazioni dinamiche): 3750 giri per cinque ore per un raggio di rotazione di 10 cm equivalenti all’effetto della gravità per un anno.