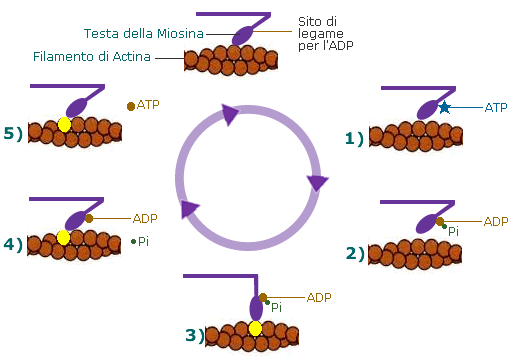Il muscolo scheletrico si contrae quando viene raggiunto dal potenziale d’azione dal nervo che lo innerva; il potenziale deriva dal motoneurone, che causa il rilascio di acetilcolina, che si lega ai suoi recettori, vi è uno sviluppo di un potenziale di placca, che nel muscolo scheletrico è sempre sopra soglia; il potenziale di azione si propaga lungo il sarcolemma, infilandosi lungo i tubuli T, li provoca il rilascio di calcio dalle cisterne terminali del reticolo sarcoplasmatico, e questo calcio innesca la contrazione agendo sul complesso troponina-tropomiosina.
Dunque il S.N.C. fa muovere la fibra muscolare accendendo il motoneurone che la innerva. Il problema è che ogni motoneurone non innerva una sola fibra, ma molte fibre; le unità motrici hanno dimensioni variabili e le fibre sono reclutate tutte insieme, ovvero o tutte o nessuna. Le fibre sono spesso raccolte per formare un unico ceppo nel muscolo, ma quando si guarda in sezione trasversa, sono disposte in maniera dispersa nel ventre muscolare. Vi sono unità motrici piccole da 2-3 fibre, e grandi, da diverse centinaia di fibre; le unità piccole daranno origine a movimenti fini, quelle grandi a movimenti grossolani.
Tramite l’elettromiografia è possibile registrare, tramite un elettrodo ad ago, gli eventi elettrici passanti per ogni muscolo scheletrico , quindi la forza esercitata dal muscolo. Se la forza sviluppata aumenta, misuriamo nell’elettromiografia, uno spike piccolo e uno spike grande, questo poiché la maggior parte delle fibre di una unità motrice è molto vicina all’ago e una è molto lontana dall’ago. Una cosa interessante da vedere è che le unità motrici non sparano mai simultaneamente, ma prima una e poi l’altra, ovvero sono intercalati fra di loro.
Le unità motrici sono interdisperse fra loro; ogni fibra di unità è intercalata con le altre, in modo che si attivino una dopo l’altra, per sommare poi i loro effetti, in maniera più regolare nel tempo rispetto all’attivazione delle singole unità motrici. Questa sommatoria di effetti assicura anche la possibilità di graduare la forza: per sollevare carichi piccoli è sufficiente una unità motrice piccola, ma per sollevare carichi pesanti c’è bisogno di più unità motrici insieme.
Per sviluppare una forza piccola è sufficiente una unità motrice piccola; e forze grandi, si usano unità motrici grandi, questo fa si che le unità motrici piccole si disattivino. La prima viene reclutata una unità motrice piccola; questa è innervata sostanzialmente da pochi motoneuroni con il soma piccolo; questo perché l’assone del motoneurone poi si arborizza a livello terminale e il soma deve produrre materiale sufficiente a produrre arborizzazioni terminali proporzionali alla grandezza dell’unità motrice.
Un motoneurone grande, che ha molti canali ionici nella sua membrana, ha una resistenza di membrana piuttosto bassa; il motoneurone piccolo invece, che ha pochi canali ionici, ha una resistenza maggiore, quindi a parità di segnale proveniente dal S.N.C. la depolarizzazione nel piccolo sarà maggiore nel piccolo, in quando la differenza di potenziale è uguale alla corrente moltiplicata per la resistenza di membrana; a resistenza bassa, il motoneurone non andrà soprasoglia. Per segnali discendenti di bassa intensità verranno attivate unità motrici piccole, ma non le grandi.
Nel midollo spinale sono presenti oltre ai moto neuroni, gli interneuroni, che possono anche essere inibitori, in quanto secernono glicina. Gli interneruroni sono di fatto quelli che controllano se si attivano o no i motoneuroni; e sono controllati in maniera indiretta dalla corteccia celebrale tramite il fascio piramidale. Quando il S.N.C. si rende conto di dover spostare un peso grande, attiva gli interneuroni secondo un pattern, selezionando i tipi di motoneuroni da attivare. Non solo le unità motrici contengono un numero diverso di fibre, ma anche cinetiche di attivazione e capacità di mantenersi attivate diverse. Il raggiungimento del picco della tensione è diverso a seconda della grandezza del muscolo e della sua funzione.
Il retto dell’occhio, il gastrocnemio e il soleo, hanno sia funzioni, che dimensioni diverse: il soleo è un muscolo posturale, si attiva quando noi siamo fermi; il retto ha funzione importante per la funzionalità dell’occhio, deve dunque essere rapido nei suoi movimenti e nel raggiungimento della tensione. I muscoli possono essere fasici (a controllo veloce) o tonici (posturali). Le unità motrici hanno cinetiche diverse e capacità di mantenere le contrazioni molto diverse; ci sono muscoli lenti (slow), capaci di risponde a un singolo impulso, e a contrarsi (50 millisecondi) senza problemi successivamente a scosse ripetute. Le unità motrici veloci invece si contraggono e si rilassano molto più rapidamente (20 millisecondi) la forza che si riesce ad ottenere da queste unità motrici è molto minore nel tempo prolungato.
La fatica muscolare si raggiunge quando, sotto stimolo del motoneurone, le unità motrici non si contraggono più; queste sono le unità motrici fast. Vi è poi un tipo di unità motrice intermedio, non riesce a sviluppare una forza pari a quella di una Fast, ma non è piccola come uno Slow, e resiste alla fatica per circa un’ora, dopo la quale anche questa sente la fatica.
In sostanza vi sono tre tipi di unità motrici: quelle che sviluppano poca forza ma sono resistenti alla fatica, quelle che sviluppano molta forza ma sono molto facilmente affaticabili e le unità motrici intermedie, relativamente intermedie, che sviluppano una forza relativamente grande e si affaticano in una scala di tempi relativamente intermedia. La fatica muscolare è dovuta alla incapacità di contrarsi della fibra; sostenuta dal fatto che sia disponibile ATP; ad un certo punto le fibre muscolari esauriscono le loro scorte di ATP e non sono più in grado di contrarsi.
La fatica significa che non c’è più ATP necessaria per i ponti trasversi e per il colpo di forza, ma tiene anche attive le pompe che eliminano il calcio da citoplasma e la pompa sodio potassio per mantenere il potenziale di membrana ad un valore ragionevole. Le fibre muscolari prendono ATP da varie fonti: la più ovvia è quella presa dall’interno della fibra, tuttavia nella fibra le scorte di ATP sono minime, non sufficiente per mantenere la contrazione per più di 10 secondi.
Questo tipo di riserva è quella utilizzata dalle fibre fast fatigue, che si contraggono molto rapidamente poiché usano ATP già pronto e vanno subito in fatica poiché l’ATP finisce. Un’altra fonte di ATP relativamente rapida è la glicolisi anaerobica; il glicogeno all’interno della cellula può essere utilizzato per produrre ATP, tramite il ciclo dell’acido piruvico, con poi produzione di acido lattico, che poi verrà trasferito dall’interno della cellula al sangue.
Il problema di questo metabolismo è il fatto che si producono grandi quantità di acido lattico, che in quanto acido, acidifica il sangue; infatti l’esercizio fisico intenso può portare ad acidosi, portando il pH plasmatico da 7,2 a 6,9. L’acidosi per altro inibisce anche la via del metabolismo, ed una più intensa non è compatibile con la vita; vi è poi il fatto che le riserve di glicogeno nella fibra muscolare sono relativamente limitate, vi sono vari modi per aumentarle, uno dei tanti è la dieta, con i carboidrati.
C’è una sola fonte di ATP sostanzialmente inesauribile, la fosforilazione ossidativa; però la fosforilazione ossidativa necessita di un continuo apporto di ossigeno alla fibra muscolare, questo metabolismo è interminabile, purchè il muscolo venga rifornito di ossigeno e allora verrà usato dalle unità motrici di tipo slow, che sono quelle che non vanno in fatica purché ossigenate. Questo è il metabolismo adatto per chi vuole dimagrire, in quanto all’ossigeno di aggiungono gli acidi grassi.
Le riserve di glicogeno sono particolarmente abbondanti nelle unità motrici di tipo fast; in quelle di tipo slow è particolarmente presente la mioglobina. il muscolo rosso tonico e lento, quello bianco, rapido e affaticabile. Muscoli molto ricchi di fibre slow, la vascolarizzazione capillare è molto ricca, mentre muscoli in cui predominano le fibre fast, hanno una vascolarizzazione limitata; i primi hanno continua necessità di ossigeno, i secondi no.